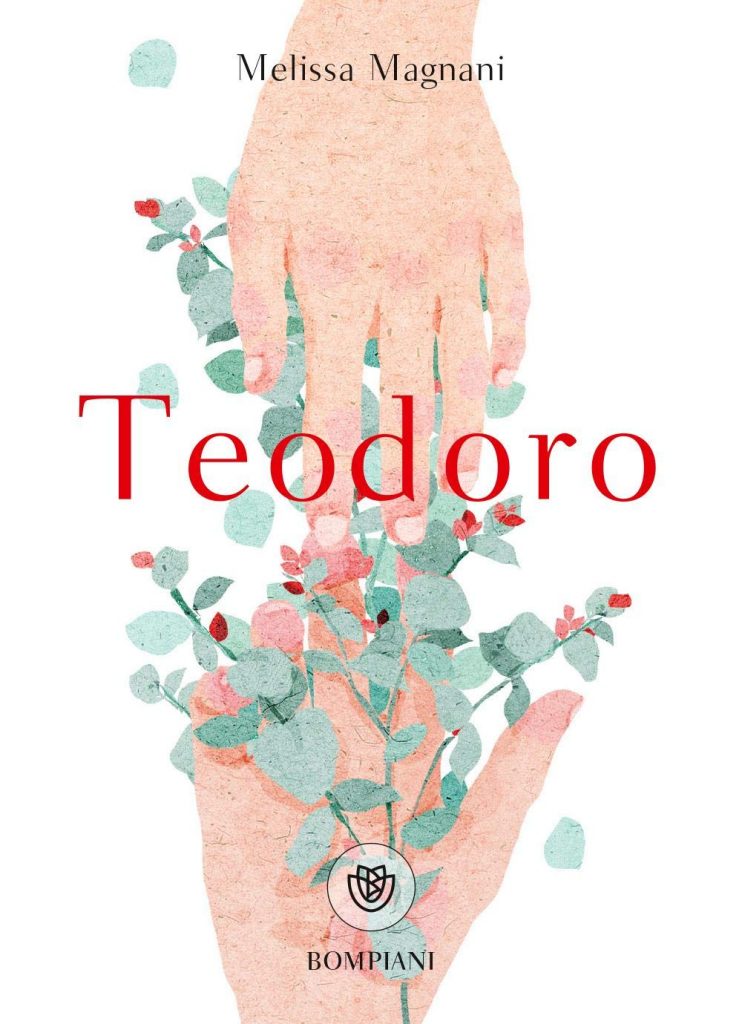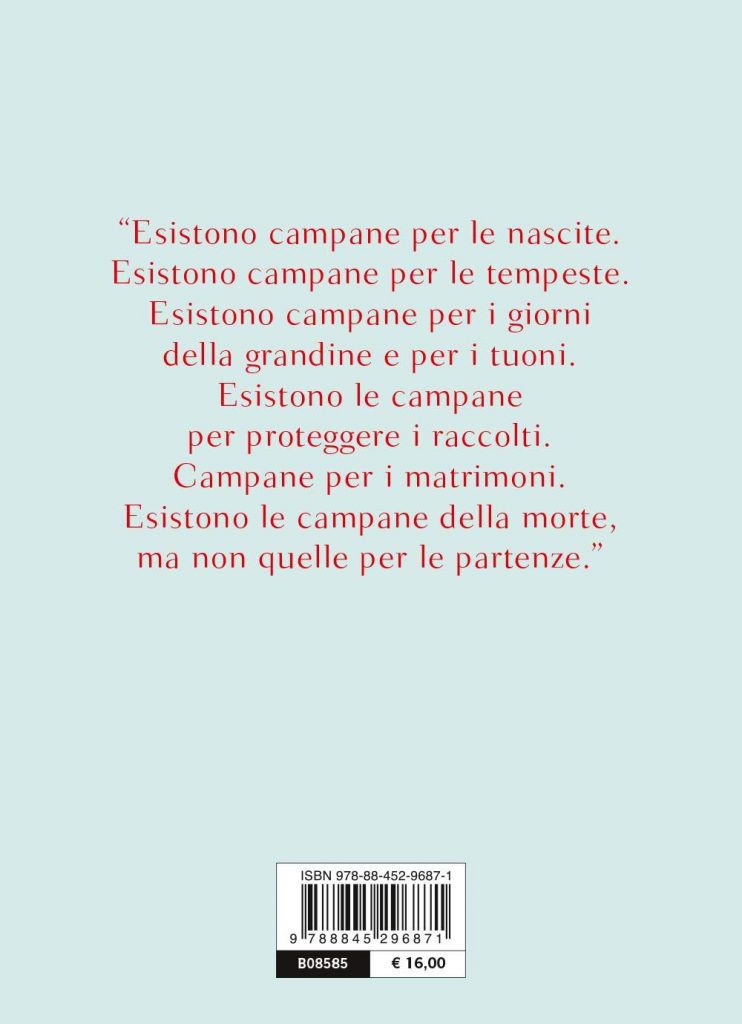Raccoglimi nelle tue mani. Dentro questa giornata di aprile, in questa pianura, su questa terra. Prendimi tra le braccia. Lega con fili il mio polso a te, che io possa non perdermi nel vento. Rimaniamo vicini, copriamoci con i nostri soli corpi. Mamma io sono il tuo bambino. Sono un’impronta bianca dentro di te. Non me ne sono andato. Rimaniamo così, stesi dentro il mondo, accanto ai cavalli che masticano biada. Mentre il cielo continua a girare e gira mio padre, lontano, intorno alla casa come un girotondo che non conosce fine.
La contiguità del mondo dei morti con quello dei vivi innerva questa struggente storia d’amore filiale, strutturata secondo un impianto narrativo implicitamente classico, di cui si apprezza, tuttavia, l’inattesa e originale efficacia poetica.
Sappiamo quanto in fondo agisca la lezione dei classici sull’articolarsi di una creatività̀ artistica e letteraria contemporanea, e non solo come serialità accademica, ma per lo spessore emotivo che riaffiora dalla vitalità degli immaginari classici, a garanzia di una immedesimazione infallibile e inesauribile lungo la storia dell’umano sentire.
Tenendo conto dei tòpoi letterari, e di certi corsi e ricorsi di una letteratura largamente considerata immortale, il romanzo di Melissa Magnani si appropria di un patrimonio letterario e umano universalmente condiviso, dandone, tuttavia, una convincente ri-configurazione lirica: il tempo agognato, inteso come età a cui fare ritorno, dove tutto è puro e idilliaco, che risuona sia in forma di Campi Elisi che di Paradiso; l’ideale contadino-popolare che vede l’uomo conservare l’armonia con la Natura e le sue leggi, che non discerne la vita dalla morte, ma semmai ne contempla l’incontro e il ricongiungimento, ponendole in una reciproca relazione di accettazione e di rispetto spontanei; l’incedere solenne, vagamente epico – mitologico, che ricorda quello di un dramma o di un poema eroico, se non fosse che è l’intimità mentale e affettiva di un neonato a occupare la scena; infine, la risonanza drammatica del teatro, e quell’atmosfera incantata da sortilegio e profezia di certe leggende e fiabe della tradizione occidentale.
Teodoro ha undici giorni quando conosce la morte. Troppo pochi perché possiamo attribuirgli un corpo e una fisionomia, ma ne catturiamo la voce che è quella delle stagioni, del tempo, dei paesaggi, dei popoli che abitano la pianura. È la voce di un morto prematuro, immacolata e pregna di una innocenza infantile e, al contempo, di una saggezza ultraterrena – a pesare sulle parole che pronuncia come la cifra simbolica di un testamento è il senso della vita – con cui incide le vicende della famiglia cresciuta dopo di lui.
Teodoro parla come un rintocco di campana annunciatrice e messaggera con cui veicola simbolicamente messaggi carichi di malinconica memoria, rigonfia di amore e risentimento per non essere più figlio, primogenito, fratello, bambino, e di promemoria, di allarme e veggenza, mentre raduna intorno a sé, alla sua presenza incorporea di un quasi spirito, la famiglia intera, chiamandone i membri per nome, a uno a uno, così da tenerli insieme, dentro quell’ordine armonico di cui è involontariamente custode. Teodoro, dunque, è un personaggio vocale, una traccia parlante dalla forte accentuazione patetica, che si muove, anzi, vaga, dentro mondi leggendari e fiabeschi (almeno, per quel filo di collegamento che da sempre unisce l’ancestrale col presente); che ricongiunge la parte di sé alle radici di una discendenza di sangue e affettiva; che unisce al dolore della sua dipartita la naturalezza con cui gli altri scelgono di andare avanti; che tiene insieme le persone ai luoghi, agli oggetti, agli animali, alle svariate forme di esistenze, immergendole in uno spazio intensamente evocativo, paradisiaco e magico, in cui il tempo scorre mantenendosi astrattamente immobile e uguale a sé stesso.
Di sottofondo, il silenzio che proviene da quella metà di umanità vivente composta dalla famiglia. Ciascun personaggio rivela una tenace fedeltà a sé stesso e alla rappresentazione di essere vivente in vita, di chi del proprio destino è in qualche maniera addomesticato. E mentre Teodoro agita i suoi ricordi perché si possa sentire ancora parte di quella genealogia, i personaggi secondari vengono osservati nel loro disinvolto e silenzioso adempimento della vita, mentre attraversano, quasi indifferenti, le tappe naturali dell’esistenza.
Vorrei dormire in una grande culla, fatta delle sue mani e delle braccia di mio padre e di tutti i miei fratelli. Vorrei riposare e su di me le loro dita, il loro tocco. Vorrei coprirmi della loro pelle ed essere solo un bambino, solo un figlio, un fratello.
Non c’è nulla di religioso – semmai di spirituale – non in questi passaggi protesi piuttosto ad abbracciare intuizioni psicologiche (oltre che filosofiche) di una visione del mondo umana acquietata e consapevole (Weltanschauung), in cui è la posizione ultima dell’anima di Teodoro a preservarne il senso di eternità.
Più che la memoria, è il tempo il vero protagonista di quest’opera contagiosa di una pacata e involontaria tristezza, come lo sono sotto sotto le fiabe, tutte buone e amare, tutte fresche e gioiose quanto ciniche e crude; come lo sono, in fondo, gli album di famiglia. È una narrazione che celebra il tempo e il suo ardore distruttivo e vitale al contempo, nonché i suoi effetti pungenti da cui tutti, con intensità diverse, siamo prima o poi colpiti: la solitudine, la nostalgia, l’attesa, l’esitazione, il desiderio, i rimpianti, ma anche la voglia di vivere, crescere, amare.
Il ricorso, poi, a dettagli sensoriali e meteorologici, caratteristica che ricorre serialmente, infusi di una scrittura sinestetica, melodica e rarefatta, ricercata fino a un purismo e una sublimazione formali estremi, incentiva la narrazione a caricarsi di echi più squisitamente commemorativi. Il lettore è destato da una memoria inconscia e inconsapevole, paradossalmente priva di ricordi episodici, ma basata sulla percezione sensoriale e simbolica: stimolati da odori, visioni, sensazioni uditive di un’esperienza non certamente ma potenzialmente vissuta lì assieme a Teodoro in un luogo non luogo, ci scopriamo persuasi dallo stesso smarrimento nostalgico per un’età di latte e di serenità innocente che ci ha irrimediabilmente abbandonati.
L’opera di Magnani si presenta così, come un romanzo di voci e sentimenti, di tracce e rinvenimenti che si ricongiungono in un luogo chiamato anima.
Paola Milicia
L’intervista
Paola Milica: Partiamo dalla più ovvia delle curiosità, ovvero, come nasce l’idea di Teodoro. È la tua prima opera narrativa, e ci piacerebbe conoscere la genesi, lo sviluppo, le incertezze – se ne hai incontrate – che ti hanno accompagnato durante la stesura.
Melissa Magnani: Ho scritto “Teodoro”, il mio primo romanzo, nel silenzio e nel segreto. L’ho scritto, perché volevo raccontare il visibile e l’invisibile, la sacralità dei legami famigliari. Durante il tempo della scrittura, osservavo le stagioni alternarsi nella pianura, la nebbia, l’afa, la neve. Sfogliavo le carte del mio albero genealogico. Appuntavo parole d’inchiostro su muri bianchi. Incontravo zingari ed eremiti. Inseguivo i merli. Raccoglievo ortiche. Scrivevo su fogli che poi strappavo. Scrivevo tutto in corsivo. Anarchica, non seguivo alcun ordine, solo l’istinto. A volte, restavo china sulla pagina per ore.
Il romanzo è un flusso di memoria, concreta e sensoriale, oltre che di evocazioni immaginarie e di reazioni “chimiche”. C’è un’immagine in particolare nella tua memoria che ti ricollega a Teodoro, o più genericamente, a quello che hai raccontato? Il romanzo conserva un passaggio della tua esperienza diretta?
Da bambina ero circondata da campi e cavalli. Mio padre mi insegnava a comprendere il nitrire dei puledri. Mia madre mi raccontava i rintocchi dei miei antenati, tutti campanari. Poi i paesaggi sono cambiati intorno a me, ma mi è rimasto addosso il fascino per quei luoghi, una pianura brulla. Così ho portato tra pagine di “Teodoro” erbe selvatiche, campi di grano, fiumi, alberi, nidi di uccelli, vigne. I luoghi descritti, tuttavia, non appartengono a nessun luogo. Le vie non esistono sulle mappe, le strade non hanno nome. La pianura di “Teodoro” è un paesaggio sospeso nel tempo e nello spazio, immaginario e immaginifico, dove passato, presente e futuro danzano, come un vento.
Nel libro i rinvenimenti classici sono definiti a partire dal principio, quando compaiono le due vecchie, la storpia e la cieca, ad annunciare la morte del piccolo Teodoro, condizione che si ripeterà per ogni altra circostanza importante della vita famigliare (un tratto che mia ha immediatamente riportato all’atmosfera leggendaria delle streghe di Macbeth). Tuttavia, com’è naturale che sia, il tuo libro comincia dove finiscono queste suggestioni…Di quale autore ti sei “servita”, hai, cioè, scelto un’origine letteraria al tuo romanzo, un’ispirazione più che più di altre ti ha guidata?
Sono molti gli scrittori che amo e che da sempre mi accompagnano con le loro opere. Ma non solo. Ci sono artisti, registi, musicisti, mistici. Mi piace chiamarli tutti per nome, come un mantra: Gabriel Garcìa Màrquez, Juan Rulfo, Bruno Schulz, Franz Kafka, Dino Buzzati, Thomas Bernhard, Thomas Merton, Tadeusz Kantor, Amos Oz, Anselm Grun, Anselm Kiefer, Mario Merz, Marisa Merz, Terrence Malick, Christine Lavant, Christian Boltanski, Anjia Plaschg, Mariam Petrosjan, Carol Rama, Bonaria Manca.
Del romanzo, rimangono impressi a lungo i paesaggi sonori: fra tutti quello delle campane. La campana suona storicamente per annunciare qualcosa. Ci sono campane per ogni circostanza: per commemorare un morto, per adunare in piazza, per festeggiare un buon raccolto, per pregare. Hanno delle suggestioni religiose e pagane, al contempo. Tutto il romanzo è pervaso da questo sconfinamento tra realtà – magia, spiritualità cristiana e pagana. Quando immergi il lettore nelle atmosfere evocative, fantasmiche, esistenziali, ad alto contenuto simbolico, è più la fede o la superstizione ad agire?
Il tempo di “Teodoro” è un tempo rarefatto, spirituale. Le pagine del mio romanzo sono intrise di ritualità. Vi sono tradizioni rurali, che legano le mani alla terra, come cucire salvia alle stoffe, pettinare con rosmarino le criniere, piantare medaglie agli zoccoli dei cavalli. Vi sono riti ebraici e cristiani. Vi sono gli amuleti degli zingari da stringere ai polsi, suoni di tamburi, fuochi nella notte, mani aperte al cielo a chiedere il futuro. Non c’è superstizione. Ci sono gesti antichi. Tutto appare magico perché tutto è sacro: la natura, gli uccelli, i fiori, le voci, gli sguardi, i gesti tra fratelli.
A proposito dei nomi. Anche i personaggi portano questo stesso marchio divino, simbolico, ancestrale, come a suggerire che l’esistenza di un uomo passa attraverso la celebrazione anche del nome e del suo recondito significato. Ad esempio, Teodoro, dall’antico greco, significa dono di Dio. Qual è stato il criterio con cui hai battezzato i personaggi di nomi indubbiamente curiosi e ricercati?
La mia storia è, in fondo, anche una storia sul donare parole. È un diario di fratellanza. Teodoro chiama per nome tutti i suoi nove fratelli. E ogni nome è auspicio e presagio, ogni nome svela un’identità. C’è Ero, poche lettere, essenziali, che contengono un segreto. C’è Gedeone, suono riposante, quieto, pacifico, come colui che lo porta. C’è Ada, dal nome palindromo, infinito, come infiniti sono i dubbi di lei. C’è Giacinto, piccolo e delicato, come fiore. Pellegrino, fratello zoppo, ma inarrestabile. Libero, imprevedibile, senza regole. Mario, insonne, sognatore. Poi Abele e Zaira, gemelli, selvatici, dal legame indissolubile che contiene tutti gli alfabeti possibili, dalla A alla Z. Non vi sono altri nomi nel romanzo. Non ho dato nomi al padre, né alla madre, affinché ognuno possa sentirsi quella madre, quel padre. Perché maternità e paternità sono di tutti, al di là del tempo, dei luoghi.
La tua tecnica di scrittura è sorprendentemente chirurgica: elimini il superfluo, assegnando alla parola una densità tattile e di espressione sufficientemente imprimente. È un esercizio da poetessa, da fine esteta e purista. Ci vuoi dire qualcosa sul metodo che adotti e la scelta delle parole?
Amo l’essenzialità, le frasi brevi come lampi, e le pagine bianche, simili a sospiri. Per “Teodoro” volevo una lingua che fosse un soffio, che respirasse. È stato un gesto naturale prendere la penna e donare a lui una voce che fosse lieve, che si alternasse ai silenzi. Lirica, ma allo stesso tempo scarna, evocativa, frammentata, musicale. Non ho un metodo. A volte le immagini si presentano a me senza una ragione. Io le traduco in inchiostro. Mi piace muovermi libera sulla pagina, come in un campo, senza punti cardinali.
Editore: Bompiani (16 febbraio 2021)
Formato: 130.0 x 180.0
Legatura: cartonato con sovraccoperta
Pagine: 272
ISBN-13: 978-8845296871