Finalista al Premio Calvino per ben due anni. Vincitore della 35ma edizione del Premio Gambrinus – Giuseppe Mazzotti 2017 nella sezione Montagna, cultura e civiltà con Paesi Alti (Edizioni Biblioteca dell’immagine),Antonio Bortoluzzi ha recentemente pubblicato ”Come si fanno le cose”(Marsilio). Protagonista ancora la montagna e i suoi abitanti, ma in un nuovo contesto mai indagato finora dallo scrittore nato in Valturcana: la fabbrica. Sono i ritmi del lavoro scandito dai turni, la ripetitività delle azioni, la crisi e soprattutto il desiderio di una nuova vita ad animare le vite dei due protagonisti, Massimo e Valentino. Stanchi della routine di manutentori in un’azienda di filati e abbagliati dall’oro custodito nella nuova ditta orafa aperta in alcuni locali dismessi della fabbrica in cui lavorano, i due amici decidono di pianificare il furto di monili per procurarsi il denaro necessario a dedicarsi al loro sogno: l’apertura di un agriturismo in montagna. A sparigliare le carte, proprio nel momento decisivo, interviene una variabile imprevedibile: l’innamoramento di Valentino per Yu, una ragazza cinese che odora di fritto e trascrive su un taccuino le nuove parole italiane che arricchiranno il suo vocabolario.
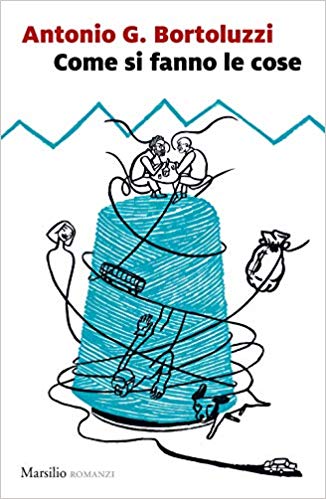
Come si fanno le cose 
Dopo la trilogia dedicata alla montagna e alle comunità del secolo scorso perché un romanzo ambientato ai giorni nostri?
I mondi che conosco sono sostanzialmente due: il piccolo borgo di montagna della mia infanzia e giovinezza e il luoghi di lavoro in cui ho vissuto e vivo. Ero in cantiere a sedici anni e lavoro da trentasei anni in fabbrica.
In “Come si fanno le cose” volevo scrivere dell’oggi e di una specie in via di estinzione, “l’operaio a tempo indeterminato”, prima che scomparisse del tutto, com’è toccato ai contadini dopo la metà del ‘900.
In cosa si assomigliano e differiscono le comunità montane e le “comunità” che si costituiscono in un ambiente di lavoro?
Mi sono accorto di una cosa: in tutte le storie che ho scritto c’è un centro che è rappresentato dal mondo del lavoro e questo è il tratto comune.Le attività umane fondono le persone in una dimensione obbligata, di sfruttamento, di fatica, che però restituisce anche un’appartenenza, un essere riconosciuti.
La differenza sostanziale tra la comunità contadina e quella industriale è che nel mondo contadino non c’era distinzione tra i luoghi di lavoro e i luoghi di vita: casa, stalla, cortile, campi, era tutto lì intorno.
Con le fabbriche e i distretti industriali da una parte e i quartieri dormitorio dall’altra si è sfaldata quella comunità del paese o del quartiere. Per decenni si è cercato di rimarginare questa frattura pensando a un’appartenenza di classe (il partito, il sindacato).
Ora siamo in una terra di mezzo in cui i grandi pensieri politici sembrano non dare più risposte e non c’è nulla di solido all’orizzonte.

“Vita e morte della montagna” di Antonio G. Bortoluzzi 
“Paesi alti” di Antonio G. Bortoluzzi 
“Cronache dalla valle” di Antonio G. Bortoluzzi
In precedenza ha raccontato di luoghi di montagna che si spopolano, di persone che abbandonano boschi, stalle e pendii attratti dalla prospettiva del lavoro in fabbrica. Ma anche quelle si sono svuotate per colpa della crisi. Gli esiti sono simili?
L’abbandono totale della vita e del lavoro contadino in montagna è stato un errore. Però c’era il grande sogno di uscire dalla povertà, di avere case più confortevoli, lavori pagati meglio, servizi essenziali. Non dimentichiamo mai la fatica nullificante e la povertà diffusa del mondo contadino e che cosa ha rappresentato la modernizzazione industriale. Quindi l’abbandono delle terre alte è stato fatto di buon grado. Ora è diverso: le difficoltà crescenti del mondo del lavoro (in particolare della manifattura) che aveva incrementato i consumi come mai nella storia dell’uomo ci lascia sbigottiti, e credo, incattiviti. Anche perché non sappiamo più “fare economia” come accadeva un tempo nelle povere case della nostra infanzia, non sappiamo quasi produrre più nulla con le nostre mani e siamo costretti a comprare qualsiasi cosa. Se cala il reddito ci sentiamo perduti.
Quanto può essere avventurosa la vita di chi lavora in fabbrica?
La vita in fabbrica non è avventurosa, magari è faticosa, alienante, oggi perfino precaria.
Ma sono le lavoratrici e i lavoratori a essere avventurosi e nelle pause dal lavoro, mentre si mangia o si viaggia tra casa e cantiere, ufficio, fabbrica la vita dei lavoratori si popola di vicende, racconti, sogni, desideri.
Questo è il mondo parallelo in cui siamo immersi tutti e tutte, ed è una miniera di storie cui ho la fortuna di partecipare da sempre.
Massimo e Valentino desiderano una vita diversa da quella della fabbrica, una vita giusta: rilevare un agriturismo sui monti. Perché rischiare la propria integrità morale commettendo un furto d’oro?
Questa è stata la prima questione su cui ho desiderato imbastire il romanzo: che cosa accade se due persone oneste decidono di rubare? Per me i due protagonisti hanno accumulato nella vita tante frustrazioni, sconfitte, mortificazioni e allo stesso tempo si sono trovati dentro la grande narrazione mediatica del “ritorno felice alla natura”:
questa situazione li ha portati a ideare, progettare, realizzare un furto e sporcarsi realmente le mani e metaforicamente l’anima. Però, nonostante tutto, qualcosa di incorrotto è rimasto in loro.
Massimo ha individuato sette tipi di lavoratori: il mona, il furbo, il paraculo, lo psicopatico, l’arrivista, il figlio di puttana, il normale. Concorda con il suo personaggio? Lei come si definirebbe?
Concordo con Massimo, sì. Per come definirmi dovrei chiedere ai miei amici e colleghi di lavoro. Però so che mi piacerebbe tanto dicessero che sono un tipo normale, magari che cade in qualcuno dei sette tipi, ma poi ce la mette tutta per ritornare alla quiete giusta dello stare insieme in un luogo di lavoro.
Quanta consapevolezza ha l’uomo moderno del modo in cui “fa le cose”?
Stiamo perdendo il rispetto per le cose e per chi le produce, ci sentiamo più consumatori che produttori. Ci arrabbiamo con gli addetti allo sfalcio ai bordi delle strade che ci obbligano a rallentare, ma tutta la nostra vita concreta, la nostra sussistenza la dobbiamo alle attività lavorative. Soprattutto degli altri e ci sono tante persone che nel mestiere che svolgono vanno oltre il proprio dovere. E i furbetti del cartellino non ce la faranno a farmi perdere la fiducia a priori che ho nei confronti di coloro che lavorano, soprattutto se il loro stipendio è basso.
Perché il fondamento della Repubblica non è la giustizia, l’amore, nemmeno i confini dello Stato; l’articolo 1 della Costituzione lo dice chiaro: L’Italia è un Repubblica fondata sul lavoro.
Valentino sostiene che le persone siano un buco, un vuoto da riempire con le cose che si fanno. E più grande è il buco, maggiore è l’impegno a fare, a dire, a provarci. Quindi la mancanza è una fortuna?
La mancanza di cui parla Valentino è una dimensione esistenziale. Gli esseri umani sembra si siano spinti molto avanti nelle loro capacità speculative, progettuali, immaginative per cui tra ciò che siamo e ciò che potremmo essere c’è uno spazio grande, che per Valentino è un vuoto da riempire con le cose che si fanno.
Non credo che questa mancanza sia una fortuna, è piuttosto una condizione da cui provare a farcela, oppure al contrario, esserne annichiliti.
Come Meneghello,anche lei ha ribadito che la comunità tiene in vita il dialetto e il dialetto tiene in vita le cose. Quando un dialetto muore svaniscono anche le cose. Qual è il termine che ricorda con maggiore nostalgia?
Mare, nel senso di mamma, che però ha un suono, una rappresentazione molto più potente. E poi rimanda al mare d’acqua, a quel colore bruno ed eterno che i greci antichi avevano nel cuore. Nel nostro dialetto veneto(che per me è la lingua materna) la mare è anche quella dell’aceto di vino ed è anche l’utero.
Ecco, mare è più di una parola, è una specie di relazione suono-cosa-senso che attraversa i secoli e noi stessi.
Cosa può fare uno scrittore per evitare che le parole muoiano?
Un po’ scriverle, un po’ dirle. Soprattutto cercare altre persone disposte a raccontare e ascoltare. Ma non è difficile, e se alle volte siamo distratti, io credo che la parola umana sia l’unico nostro super potere (proprio come i super poteri degli eroi dei fumetti). La parola detta, scritta, ascoltata è uno strumento così avanzato nella tecnica, nei contenuti, nelle simbologie da essere la nostra natura, ormai inseparabile dal corpo.
