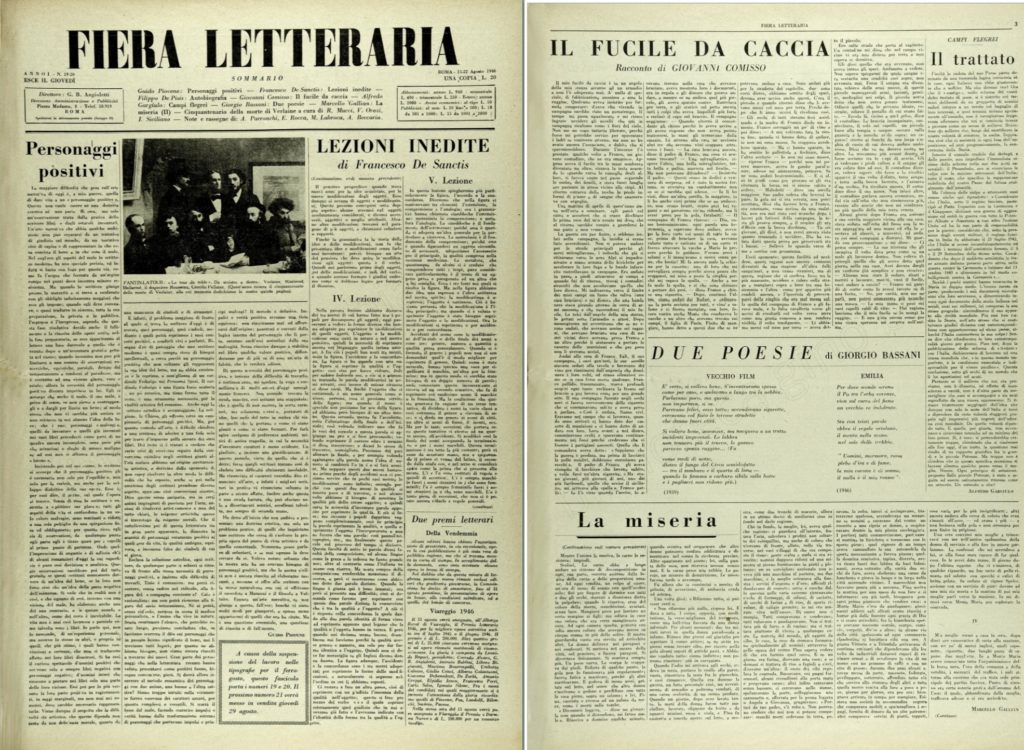Il mio fucile da caccia è in un angolo della mia stanza accanto ad un armadio e non l’ò adoperato mai. Ha nulla di speciale, di fabbricazione anonima e ama la ruggine.
Qualcuno aveva insistito per farmelo comperare, diceva che vivendo in campagna sarebbe stato un passatempo. Il tempo mi passa ugualmente e mi riesce ingrato uccidere gli uccelli che qui in campagna risultano come i fiori del cielo.
Non me ne sono tuttavia liberato, perché forse mi potrebbe servire per spaventare i ladri se venissero attorno, ma non ne ho avuto ancora l’occasione, e dubito che si spaventerebbero.
Durante l’inverno l’ò prestato qualche volta a Franco, un giovane contadino, che ne era smanioso. Appena aveva il fucile tra le mani sembrava diventare un altro, rizzava la testa acuendo lo sguardo verso le ramaglie degli alberi, si faceva cauto nel passo seguendo le ombre dei fienili, e stava fuori lunghe ore paziente in attesa vicino alle siepi. Al ritorno estraeva dalle tasche le prede informi di piume e di sangue che enumerava con orgoglio.
Una mattina di aprile di quest’anno stavo nell’orto a seminare, egli passò col carro e accortosi che si erano dischiuse le prime rose del mio rosaio mi disse che al ritorno sarebbe venuto a prendersi la sua parte e non venne.
La guerra era per finire, e sebbene isolati nella campagna, le insidie si erano fatte accerchianti. Non si poteva andare per le strade principali perché gli aerei mitragliavano, i tedeschi che già si ritiravano verso le nere Alpi si impadronivano a mano armata delle biciclette per accelerare la loro fuga e le bande inferocite rastrellavano la campagna.
Ero andato in paese a piedi attraverso ai campi e quando fui di ritorno, trovai contadini stravolti che non ascoltavano quello che loro dicevo. Mi indicarono verso il limite dei miei campi un fumo che saliva (una casa bruciava) e mi dissero che una banda nera stava girando attorno in cerca di armi nascoste e che nascondessi il mio fucile.
Lo tolsi dall’angolo della mia stanza, lo gettai sotto l’armadio e attesi. Dopo mezzogiorno mi avvertirono che se ne erano andati, che avevano ucciso sei ragazzi, che avevano bruciato una casa di nostri vicini dove avevano preso Franco e un altro perché li aiutassero a portare le cassette delle munizioni e che per poco non li avevano uccisi.
Andai alla casa di Franco. Egli, il suo compagno, i suoi genitori, le sue sorelle stavano seduti alla tavola e bevevano del vino per rianimarsi dall’angoscia che dominava i loro volti, ed erano silenziosi come se in casa fosse morto qualcuno. Franco pallido, trasumanato, traeva profondi sospiri ogni tanto reclinava la fronte sul braccio e poi beveva come per una grande sete.
Il suo compagno furente negli occhi neri si faceva nervosamente delle sigarette che consumavano subito e aveva preso a parlare.“Così è andata. Siamo vivi. Eravamo nel campo che si lavorava, quando sono arrivati ci hanno dato due cassette di munizioni e ci hanno detto di andare con loro. Loro avanti e noi dietro, camminavano svelti e sparavano continuamente nei fossi perché credevano vi fossero i partigiani nascosti. Quello che li comandava aveva detto: “Sappiamo che la guerra è perduta, ma prima di lasciarci la pelle noialtri, dobbiamo sterminare parecchi”.
Il padre di Franco gli aveva riempito il bicchiere che bevette subito, e volle farsi un’altra sigaretta.
“Ma erano giovani, più giovani di noi, uno dei più furibondi, quello che uccise il siciliano, mi arrivava alla spalla.”
Franco parlò: “Io l’ò visto quando l’uccise, lo avevano trovato nella casa che avevano bruciato, avevano mostrato loro i documenti, era in regola e gli dissero che poteva andare, e mentre se ne andava quel più piccolo, gli aveva sparato contro. Rantolava per terra, e gli scaricò sul petto ancora tutti i colpi che aveva. Impallidì più forte e reclinò il capo sul braccio“.
Il compagno soggiunse: “Quando ritornò il comandante gli chiese perché lo aveva ucciso e gli aveva risposto che non aveva potuto trattenersi, le mani gli tremavano dalla smania. Là attorno alla casa ne uccisero altri tre che avevano visti scappare attraverso i fossi.”
“La casa bruciava ancora”, disse il padre di Franco, “ma cosa vi avevano trovato?”
“Una mitragliatrice”, rispose l’altro, “una bella mitragliatrice, tutta bella e pulita, nascosta nel fienile”.
“Ma non potevano difendersi?”, insistette il padre.
“Questi erano in dodici e vennero di sorpresa, ed è stato la nostra fortuna, se avveniva un combattimento non so se si sarebbe qui adesso.”
“Io li ho visti”, disse un’altra sorella, la maggiore, “io li ho anche visti prima che se ne andassero, non erano brutti, erano anzi bei ragazzi e mi passano vicino ridendo, ma li avrei presi per la gola, farabutti!”
Il compagno di Franco riprese: “Dio come bestemmiavano, ogni parola una bestemmia, e sapevano dove andare, avevano le carte coi nomi di tutte le case, prima di bruciare la casa, avevano rubato tutto e caricato su di un carro vi fecero attaccare le vacche e Mario lo presero perché le guidasse. S’erano presi i salami e li mangiavano a morsi senza pane, che bestie! Mi fa ancora male la schiena per la cassetta; uno di loro che mi sorvegliava sempre perché aveva paura che scappassi, mi mise a posto la cinghia perché mi segava la spalla.”
“Anche a me fa male la spalla, e sì che sono abituato a portare dei pesi”, disse Franco e chiese una sigaretta.

“Dopo”, continuò l’altro, “siamo andati dai Badari, e ordinarono la pasta asciutta per tutti, e vino e salame e ci fecero mangiare con loro, fecero venire anche Mario che conduceva le vacche e un altro che avevano trovato sui campi, il figlio di Pasin. Finito di mangiare hanno detto a questi due che se ne potevano andare a casa. Sono andati giù per la strada del capitello, due sono corsi dietro, abbiamo sentito degli spari, devono avere ucciso anche questi. C’era il piccolo e quando ritornò disse che li avevano messi col naso per terra. Perché dopo che li ànno uccisi li rivoltano così.”
Gli occhi di tutti stavano fissi ascoltando e la madre di Franco diede un lamento. Franco sorseggiò un po’ di vino e poi disse: “A noi volevano fare la stessa fine, quando ci hanno detto di andare io non mi sono mosso. Se scappavo avrebbero sparato.”
“Ma ci hanno sparato. Io ho sentito le pallottole a fischiare,” disse l’altro eccitato.
“Io non mi sono mosso,” riprese Franco, “perché non mi potevo muovere, avevo le gambe paralizzate, adesso mi ammazzano, pensavo. Se ne sono andati bestemmiando.”
E si alzò in piedi come per provare se gli era ritornata la forza, mi si rimise subito a sedere.
“Maledetti” disse sua sorella maggiore. Suo padre voleva che bevessi io pure, la gola mi si era serrata, non potei accettare, dissi che facesse bere a Franco, era estenuato, come uscisse da una malattia, e non era mai stato così neanche dopo i lavori più faticosi della campagna, la testa gli pesava sempre, e il respiro gli era difficile con la bocca dischiusa.
“Tu sei giovane”, gli dissi, “e non avevi ancora visto quanto tremendo è uccidere. Dio ha voluto darti questa prova per preservarti tra i buoni.”
Sollevò lo sguardo verso di me e sorrise con pesantezza.
Uscii sgomento; questa facilità ad uccidere, questi ragazzi non ancora ventenni erano diventati da una stagione all'altra folli sanguinari, e non erano stranieri, ma di questa regione che si credeva fosse tra le più mansuete, uccidere e ridere sulla strage e mangiarci sopra e bere tra una bestemmia e l'altra come per apparire più crudeli ancora, e l’ipocrisia di preoccuparsi della cinghia che era malmessa sulla spalla del compagno di Franco e gli faceva male, e la falsa cavalleria verso gli uccisi di rivoltarli con il volto verso terra come una grazia concessa a non rendere visibile il volto trasfigurato.“Li abbiamo messi col naso per terra”, aveva detto il piccolo.
Ero sulla strada che porta al capitello. Un contadino mi disse che nel campo vicino vi era uno disteso per terra e non sapeva se dormiva. Gli disse quello che era avvenuto, non aveva inteso gli spari.
Andammo a vedere. Non sapevo spiegarmi da quale sangue era scaturita una crudeltà così aspra, non avvenuta mai. Forse il sangue era diventato schiavo delle armi nuove, di queste piccole maneggevoli armi, lucenti, precise, molteplici nei colpi. ll piccolo aveva detto che non aveva potuto trattenersi. Odiavo quelli che le avevano ideate, costruite, odiavo il metallo di cui erano fatte.
“Eccolo là vicino a quel gelso”, disse il contadino. Le braccia insanguinate, rannicchiato, il sole sui capelli, un piccolo buco alla tempia e sangue seccato sulla guancia e le mosche avide sopra: un ragazzo! Stretto ai fianchi da una larga cinghia di cuoio di cui doveva andare ambizioso.
Dissi che ve ne doveva essere un altro. Lo trovammo più avanti dentro al fosso asciutto tra le siepi di acacie. Gli si vedevano i piedi callosi e il sangue gli era colato fino ad essi. Il contadino discese, voleva sapere chi fosse e lo rivoltò: apparve il suo volto disfatto, tutto sangue e terra nella bocca lacerata, e l’azzurro d’un occhio. Fu rivoltato ancora, il contadino disse il suo nome. Non intesi altro, il contadino parlava ancora sconnesso.
Andai via sull’erba che non riconoscevo più, rasente alle acacie che non mi sembravano più quelle della mia terra Veneta.
Alcuni giorni dopo Franco era assieme a sua sorella maggiore vicino alla sua casa, stava seduto sull’erba del fosso con la testa appoggiata ad una mano ed ella lo esortava ad alzarsi, a muoversi, ad andare coi suoi compagni a distrarsi. Mi guardò con preoccupazione e mi disse: “Ci pensa sempre”.
La sua tristezza, che gli incupiva il volto, dava pena come se un male gli lavorasse dentro. Non volevo ripetergli quello che gli avevo detto quel giorno nella sua casa. Avrei dovuto dargli un conforto più semplice e non riuscivo: “Almeno non stare lì seduto, alzati e mettiti a lavorare, muoviti, vuoi il fucile, vuoi andare a caccia?”
Franco mi guardò di scatto come lo avessi toccato su di una ferita: “No per carità, non me ne parli, non potrei ammazzare più neanche una mosca”.
La mia mano si posò sui suoi capelli caldi di vita: “Hai ragione lasciamo che il mio fucile se lo mangi la ruggine”.
E una gioia serena come per una sicura speranza mi sorgeva nell’anima.
Giovanni Comisso