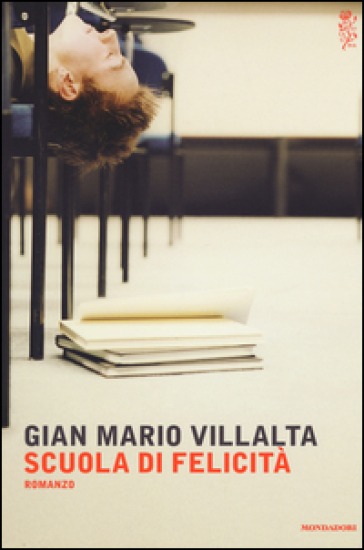La scuola e gli esami sembrano non finire mai, anche d’estate. Lo sanno bene gli studenti che devono riparare a settembre e quelli che dopo la maturità devono sostenere il test di ammissione alle facoltà a numero chiuso. Lo sa anche chi sta dall’altra parte della cattedra, come il “prof” Gian Mario Villalta che lo scorso 27 luglio, con la sua raccolta Telepatia (ed. LietoColle) ha appena vinto il Premio nazionale di poesia Carducci e che qui intervistiamo per Scuola di felicità, il romanzo con il quale ha concorso all’edizione 2017 del Premio Comisso.
Nell’ambientare questo romanzo in un liceo è stata più forte la spinta della sua esperienza personale di insegnante o la convinzione che la scuola possa essere ancora un luogo rappresentativo della società d’oggi?
La scuola è più importante oggi di ieri, direi, perché si trova al centro di molti temi e momenti dell’esperienza che in passato coinvolgevano di più e diversamente famiglia, comunità territoriale – quartiere, parrocchia – e società civile. Per anni, le ragazze e i ragazzi che arrivano alla scuola superiore hanno avuto la necessità di “iscriversi” a qualcosa (nuoto, ballo, musica, etc.) per praticare una socialità.Quando guadagnano autonomia, lentamente, alle superiori, si trovano di fronte a scelte e decisioni che diventano molto grandi. La scuola – prima di tutto come “contenitore” di tutte quelle ore della vita – diventa fondamentale anche come ambiente, quindi, come luogo speciale. Il fatto di conoscerne bene almeno uno, di questi luoghi, poiché insegno nella stessa scuola da molti anni, spero mi abbia aiutato poi a catturarne, in certi passaggi, l’atmosfera.
La felicità non fa letteratura e Scuola di felicità, infatti, è un romanzo in cui conflitti, tensioni e contraddizioni si respirano, anche letteralmente parlando, già dalle prime pagine. Conflitti vissuti a livelli diversi.
Non possono mancare i conflitti, a quell’età, anzi, nel momento in cui non ci sono è chiaro che stiamo nascondendoci qualcosa. Questo per parlare di chi – lo si ripete sempre – dovrebbe essere al centro dell’insegnamento: gli alunni. Con i genitori, con i professori, con i compagni di classe, è impossibile che non ci sia conflitto. E per conflitto intendo quel trovarsi faccia a faccia con le proprie diversità, di fronte alla costrizione dello stare insieme e di dover sottostare a degli obblighi. Poi ci sono le tensioni che riguardano la gestione della scuola, il ruolo impiegatizio in cui sono stati declassati gli insegnanti, la mancanza di riconoscimento assecondata e rivoltata in astio. E ancora, sì, le contraddizioni, nel libro ci sono molti casi. Non deve rendere felici la scuola, deve formare.
Il bisogno di dialogo, compreso quello con la natura, la terra, è un’esigenza che anima, con sfumature diverse, tutti i personaggi, persino il protagonista, apparentemente il più refrattario. Quanto ha a che fare questo bisogno con la ricerca e il desiderio di felicità, quella che non ha nulla a che spartire con la “felicità interna lorda”?
La felicità, come la intendiamo noi oggi, è un apice, un climax dell’esperienza, alla possibilità del quale dovremmo forse credere impegnandoci a perseguire mete importanti e bellezza vera, quella che viene dall’interrogazione del senso del vivere. E’ questo impegno che credo manchi oggi, anzi, direi che ne manca la mancanza, poiché quel vero impegno viene sostituito dalla banale esecuzione di una serie di obblighi. Sempre più di frequente lodiamo i “bravi ragazzi” perfettamente conformi alle nostre aspettative. Ma il vero dialogo viene da una domanda diversa da quella che pretende l’esecuzione del compito assegnato.
L’ascesa e la discesa fisica all’interno della scuola, dal piano della dirigente, passando per il piano terra delle “classi terminali” e della biblioteca, fino all’interrato, al pozzo, può essere letto anche come una catabasi che si contrappone all’anabasi?
Sì, e ancora di più, tutto il gioco del “sotto” e del “sopra”, dell'”alto” e del “basso” e dei loro rovesciamenti, corrisponde alla volontà di mettere in ironico intreccio alcune delle fondamentali categorie del nostro agire e alcuni simboli millenari, che oggi appaiono annebbiati, se non proprio obliati. Oggi la salita, l’innalzarsi, l’ascesa ha acquistato caratteri orizzontali (10.000 mi piace alla foto del tuo gatto), così come la discesa, il ripercorrere la via verso l’inizio hanno perso di pathos (torna al via!, un po’ come il gioco dell’oca). Spero che il lettore percepisca questa ironia e ne colga gli elementi che la compongono.
Il protagonista, verso la fine del romanzo, riflette sulle fotografie ed evidenzia un altro contrasto: quello tra le foto stampate e conservate, perché piene di tempo, e gli scatti degli smartphone o i selfie. È solo la nostalgia di un non nativo digitale?
Non ho alcuna nostalgia del passato. Però ho necessità di comprenderlo e di confrontarlo con il presente per capire chi sono e per capire gli altri. Anche quando ci sono delle diversità (non mi sono mai fatto un selfie) non mi interessa tanto giudicare quanto comprendere. E’ certo però che l’uso attuale delle immagini, il loro immagazzinamento a perdere, l’affidamento quasi totale a una memoria virtualmente eterna, incideranno sui comportamenti e sui sentimenti, lo stanno già facendo, lo hanno già fatto.
C’è un altro dialogo molto interessante: quello tra i vivi e i morti. Il professore, vedovo da cinque anni, si arrende all’impossibilità di cancellare tutto quello che è riconducibile alla memoria della moglie, convincendosi, alla fine, che ella abbia solo cambiato modo di stargli accanto e parlargli.
Sì, abbiamo letteralmente cancellato la morte e il lutto dalla nostra vita sociale. Questo fa sì che ognuno se ne deve caricare il peso e portarlo da solo. Per secoli, pratiche sociali, rituali collettivi, comportamenti codificati permettevano di accompagnare la persona che era venuta a mancare in una nuova dimensione della nostra vita.
Oggi, secondo l’idea corrente, dovrebbe sparire per sempre nella morte. Ma come è possibile che avvenga, se quello che abbiamo vissuto con questa persona fa parte di noi, siamo noi? La morte diventa un’amputazione.
Silenzio, caffè, una parete vuota da osservare: è la ricetta del protagonista nei momenti di difficoltà. È un metodo che utilizza anche lei o che consiglierebbe?
La solitudine, l’azzeramento di stimoli esterni – a parte il caffè, che andrebbe visto, invece, come un gesto di concentrazione – sono necessari per liberare l’immaginazione e quelle forze inconsce che partecipano a qualsiasi genesi creativa.
“Fare il vuoto” significa creare lo spazio dove la pienezza delle cose trova un luogo, una scena. Ognuno di noi, in un certo senso, per trovare la propria originalità deve azzerare o almeno ridurre di molto la quantità enorme di informazioni, suoni, immagini che verniciano la mente con implacabile costanza.
Le dinamiche e le problematiche interne alla scuola rivelano la sua esperienza diretta. Ma c’è qualcosa di cui avrebbe voluto scrivere e che invece ha scelto di tralasciare?
Mi sarebbe piaciuto pronunciarmi più a fondo sul senso della trasmissione di un sapere, sulla formazione (che cos’è, perché ha senso parlarne). Ovviamente una formazione che è tutto il contrario di quelle specie di “tutorial” in cui adesso ci si accontenta di barattare una pratica facile al posto di una conoscenza difficile. Insomma, mi sarebbe piaciuto immergermi di più nel tema di quella che viene chiamata “didattica”. Ma il romanzo, così com’era concepito, non lo sopportava.
Lei insegna al liceo dai primi anni Ottanta e ha vissuto il ciclico ripetersi di un confronto con ragazzi dai quindici ai diciotto anni. Come sono cambiati i giovani? C’è qualche loro atteggiamento che la preoccupa?
Sono cambiati di più i loro genitori e i loro insegnanti. Sono cambiati i valori e l’immaginario sociale. E’ cambiata di più la scuola. I ragazzi, a quell’età, sono sempre gli stessi, nella sostanza: vogliono crescere, conoscere, acquisire un’identità. Le differenze sociologiche e comportamentali sono più l’effetto di una vita che per molto tempo è stata strutturata da altri – a quindici anni hai potuto scegliere ben poco – che del loro vero “io”.
Professore, poeta, scrittore, critico e da una quindicina di anni direttore artistico di Pordenonelegge, uno degli eventi culturali più importanti in Italia: come ha vissuto questa crescita e come vive questa impegnativa esperienza?
E’ un’avventura. Come tutte le avventure è stata necessaria l’immaginazione, fondamentale il rischio, irrinunciabile l’affettività: fin dall’inizio è stato il lavoro di un gruppo di amici. Si impara molto, da un’esperienza del genere, soprattutto si capisce che non c’è mai un modello da imitare ma una forma da inventare, e quella forma deve venire da quanto di più forte e originale possiamo trovare in noi stessi.
Gli italiani leggono poco, lo dicono i numeri. Come si rapportano alla poesia?
La poesia è una questione di relazioni tra poeti – e amici di poeti -, oramai, e per assurdo questa sua assenza di mercato la rende più libera e vitale, anche se in certi casi più ingenuamente pretenziosa. Non mi pare che oggi gli italiani, in generale, abbiano qualche interesse per la poesia, se si intende in questo senso che la ritengono una parte vera e necessaria della loro “cultura”.
E mi pare anche che una parte della cultura letteraria e filosofica in genere sia più un atteggiamento che una necessità. La rincorsa del lettore, se significa, come pare stia accadendo, cercare a tutti i costi di adeguarsi all’orizzonte di ricezione più semplice, ci sta già regalando brutte sorprese. Se prevale la ricerca a tutti i costi della “notiziabilità”, dell’effetto emotivo immediato, della facilità di lettura – caratteristiche che si possono trovare anche in un capolavoro, però – si finisce per forza con il produrre una quantità di libri piatti e uguali. Intendiamoci, ci si può benissimo appiattire sull’ideologia della diversità, del bisogno, etc. Ho scelto una scuola di provincia frequentata dal ceto medio e medio alto (anche se non mancano casi diversi) non solo perché quella è la mia esperienza: l’ho fatto perché credo che non solo le periferie urbane delle metropoli o il sud abbandonato a se stesso siano degni di attenzione e interesse.
E anche per un altro motivo: un grido è tragico, è la poesia; continuare a gridare senza sosta per anni e anni mi sembra che dovrebbe generare la sazietà e il ridicolo. Invece non è così.