Incontriamo Vittorio Giacopini (Roma, 1961, romanziere, saggista, giornalista) ai margini di una presentazione alla libreria Tra Le Righe di Conegliano e ne approfittiamo per una lunga chiacchierata a partire dal suo libro, L’orizzonte degli eventi, Mondadori 2024.
L’orizzonte degli eventi è davvero rara avis nell’attuale panorama letterario italiano: una sorta di danza macabra e ilare al tempo stesso, in cui, attraverso i discorsi tra un disorientato “io-tutti” e uno Zingaro logorroico e maldicente, sfilano in parata luoghi comuni, paranoie, riflessioni, timori (molti) e speranze (poche) che la pandemia ha portato con sé. Lo Zingaro proviene da “un’altra parte” e irrompe nella vita del narratore (e dei lettori con lui) trascinandolo in un viaggio attraverso il passato, il presente e quel poco che rimane del futuro, inghiottito com’è “dall’orizzonte degli eventi” (in fisica, la superficie limite dei buchi neri oltre la quale nessun evento può influenzare un osservatore esterno). Un po’ Sancho Panza e don Chisciotte, un po’ Bouvard e Pécuchet, un po’ Diderot e il nipote di Rameau (ma un po’ anche Stanlio e Ollio), i due parlano instancabilmente, discutono, si accapigliano, convergono, dissentono, pontificano, teorizzano e infine sghignazzano. Pamphlet o conte philosophique, comunque romanzo di idee come da tempo non se ne leggevano e contemporaneamente, sberleffo liberatorio e apotropaico.
Tra i molti saggi e romanzi di Vittorio Giacopini, ricordiamo Re in fuga (Mondadori 2008, vincitore Premio Comisso), Il ladro di suoni (Fandango 2010), L’arte dell’inganno (Fandango 2011), Non ho bisogno di stare tranquillo. Errico Malatesta, vita straordinaria del rivoluzionario più temuto da tutti i governi e questure del Regno, (Eleuthera, 2012), Nello specchio di Cagliostro (Il Saggiatore, 2013), La mappa (Il Saggiatore 2015, finalista al Premio Campiello), Roma (Il Saggiatore, 2017), Il manuale dell’eremita (ed. dell’Asino, 2018), Fantasmi e ombre. Roma, James Joyce e Giordano Bruno (Sossella 2021, coautore Enrico Terrinoni, illustrazioni di VG).
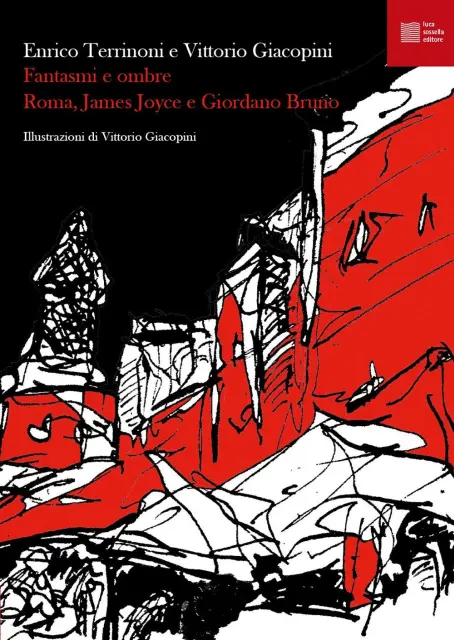


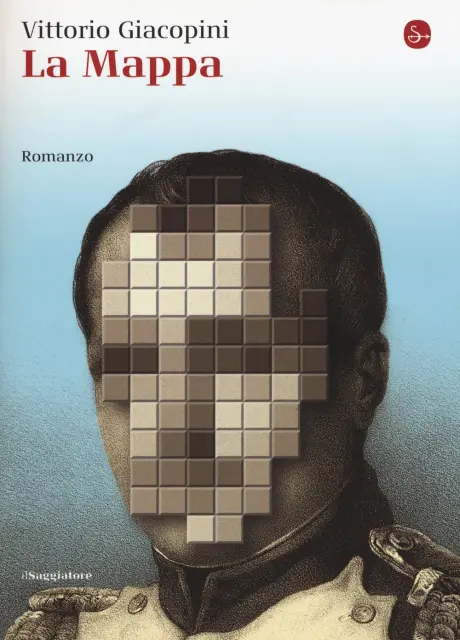


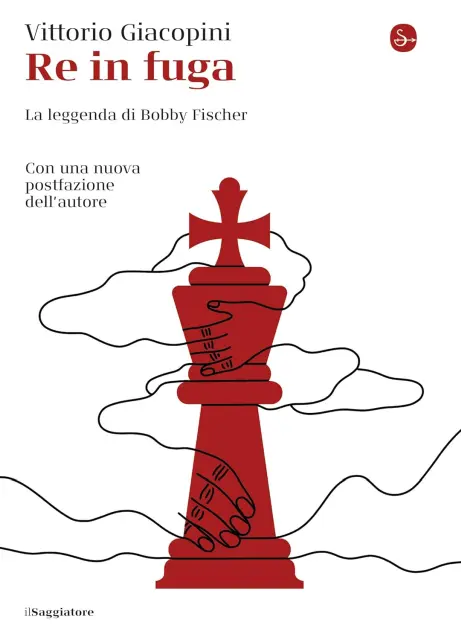

L’intervista
[Nicola De Cilia]: Ne L’orizzonte degli eventi, si accampa con simpatica protervia un personaggio impegnato in dialettica tenzone col narratore, uno Zingaro dagli occhi azzurri, che definisci “diversamente diverso”. Da dove sbuca?

[Vittorio Giacopini]: Mi serviva un punto di vista soggettivo, e questo romanzo non potevo che scriverlo in prima persona. Ma la prima persona semplice rischia sempre di essere noiosa, o qualcosa di didascalico o piagnucoloso, a me invece serviva un dialogo, avevo bisogno di un contronarratore. Dal momento che il narratore è molto idiosincratico e al tempo stesso vuole rappresentare un io-tutti, ci voleva qualcuno che potesse contrastarlo, qualcuno che fosse fuori da quel paradosso in cui stavamo confinati. Mi serviva una figura diversa ma diversa da sempre: gli zingari, col loro nomadismo, la loro erranza, sono sempre stati parte della nostra società e al tempo stesso assolutamente estranei, figure sempre vissute accanto a noi senza mai farsi ridurre a quel che siamo: beh, uno zingaro mi sembrava la figura perfetta. Tra l’altro, non è la prima volta che si incontrano zingari nei miei libri: al termine de La mappa, il cartografo di Napoleone a un certo punto finisce in una compagnia di teatranti che sono chiaramente zingari, quelli della tradizione letteraria, gli stessi che incontra Wilhem Meister nella Educazione teatrale di Goethe. Hanno sempre rappresentato un sogno di libertà, gli zingari, quindi mi serviva questa figura “diversamente diversa”. Si intende che questo è uno “zingaro metafisico”, non c’è niente di sociologico nel libro, non si parla mai di rom, di sinti, si dice zingaro o zigano o zingano. Degli zingari non si sa nemmeno da dove origini il loro nome, neppure da dove vengano, al più lo si suppone, ma loro stessi non lo sanno. I primi sono arrivati nel ‘400, poi hanno cominciato a muoversi e a fare un lungo viaggio per l’Europa arrivando in Francia, Spagna e Portogallo. Insomma, questo popolo che non si sapeva da dove sbucasse e non si sapeva cosa volesse, si muoveva nell’Europa e si sono moltiplicate una serie non solo di nomi ma anche di misure di contenimento, per cui lo zingaro è anche una sorta di proto-virus, in qualche modo. Alla fine, la soluzione era sempre quella: li pigliamo, li bruciamo, li cacciamo. Ieri come oggi. Quindi, zingaro come figura altra, come sguardo diverso su di noi, ma anche come problema che la nostra beneamata modernità si è posto solo in forma di distruzione: non a caso – e se ne parla poco – durante la seconda guerra mondiale accanto all’Olocausto c’è stato il porajmos, il “grande divoramento”, come lo chiamano loro. Gli zingari sono stati sterminati nei lager nazisti alla stregua degli ebrei. Ad Auschwitz, ci fu un tentativo di rivolta e li hanno massacrati tutti. Anche il mio zingaro ha a che fare con Auschwitz: infatti, è diverso pure dagli altri zingari, ha gli occhi azzurri (caratteristica assente tra quel popolo), e ha gli occhi azzurri perché ad Auschwitz il dottor Mengele praticava esperimenti sull’iride degli zingari, con iniezioni intravitreali: iniettava del blu di metilene nella cornea per rendere i loro occhi azzurri. Il risultato era che questi ragazzi o morivano o diventavano ciechi, nella realtà, ma nella finzione, il mio zingaro è modificato da Mengele, che sarcasticamente chiama paparino, e ha gli occhi azzurri.
Hai accennato agli zingari come sorta di proto-virus, e il tuo romanzo si sviluppa proprio durante la crisi pandemica: mi sembra che tu abbia voluto sfruttare quell’emergenza in quanto in grado di svelare qualcosa di decisivo sul nostro modo di stare al mondo, è così?
Esatto, la pandemia è stata una sorta di reagente che ci ha permesso di verificare fino in fondo quanto si fosse esaurita, incartata, un certo tipo di socialità: ha dimostrato quanto a fondo fosse mutato un certo modo di vedere i rapporti tra di noi, dimostrando che, dopo che era venuta meno l’idea stessa della politica come trasformazione, come creazione di forme più avanzate di società, si stava oramai esaurendo la normale socialità tra le persone. Insomma, in quell’occasione, quando si è scatenata la pandemia, mi è sembrato che tutte quelle misure di contenimento venissero in realtà bene accettate, quasi si trattasse di una agognata liberazione da una socialità che non andava più da nessuna parte. L’altra rivelazione, chiamiamola così, è stato anche accorgersi che quello che restava della politica si stava trasformando in una specie di parodia: la politica si identificava con le autorità che dovevano inventare nuove forme di vita obbligatoria. Il confinamento, le autocertificazioni hanno prodotto, da una parte, immediati conformismi e nuove obbedienze (dimostrando quanto facile fosse adeguarsi a nuovi schemi di vita); dall’altra, si sono scatenate tutte una serie di false rivolte, dai novax ai complottisti: è stato un evento che coinvolgendo tutti e bloccando la vita di tutti a partire da un fatto banale, se vuoi (in fondo, cosa c’è di più microscopico di un virus?), ci ha costretto tutti a guardarci allo specchio. Improvvisamente ci siamo trovati a vivere in una sospensione, come se l’angelo della Storia di Paul Klee e Walter Benjamin fosse improvvisamente precipitato. Ora, questa sospensione della Storia per chi, come me, viene da un’idea politica e filosofica della Storia come movimento, come tentativo difficile di andare verso il meglio, era folgorante per questo: avevamo già la percezione che la Storia si fosse bloccata ma ora quell’episodio rivelava l’esattezza di quella intuizione, e brutalmente ce la metteva sotto gli occhi, squadernandola davanti a tutti. Da lì, però, bisognava ricominciare a guardare questo nostro mondo, che s’era, come dire, fermato, bloccato.
Infatti, nel libro individui un momento preciso in cui “s’è rotta la Storia… s’è rotto il Tempo” e questo momento sono gli anni ’70.
Sì, con gli anni ’70 è finita un’idea di rapporto tra storia e politica, tra storia e azione umana, un’idea che aveva attraversato tutta la modernità: l’attività più alta dell’essere umano era esattamente costruire e indirizzare la polis in un certo modo, con una priorità fondamentale della politica sulla finanza e su altre forme. Con gli anni ’70 questa speranza è finita, e con essa non soltanto l’illusione della rivoluzione, dei movimenti, è finita proprio una struttura, muore quel rapporto tra politica e storia che aveva caratterizzato la Modernità, e ci siamo trovati in un mondo dove la dimensione dominante era un’altra. È anche vero, però, che durante la pandemia, la situazione ha evidenziato uno strano paradosso: ci si è accorti che la Storia è tornata a essere centrale. In quella crisi, per la prima volta, tutta l’umanità s’è messa di fronte allo stesso identico problema. Gli umani hanno sempre vissuto la Storia in modi geopoliticamente molto determinati, perfino la seconda guerra mondiale è stata una somma di crisi locali, poi l’abbiamo chiamata guerra mondiale perché ha coinvolto un po’ tutti ma era comunque vissuta da ciascuno in modo diverso. La pandemia invece è stata una guerra senza nemico che però ha fatto il giro del mondo. La globalizzazione a fine anni ’90 sembrava avrebbe portato il benessere e la felicità per tutti; dopo la crisi economica mondiale del 2008, è diventata qualcosa di completamente diverso dalle attese e sono ricominciati i conflitti, la guerra in Siria, le primavere arabe, un mondo che si stava tutto sbrindellando. Improvvisamente arriva questo virus e ci ritroviamo tutti con lo stesso problema. Un cortocircuito, la fine dell’idea di Storia voluta, controllata, trasformata dagli umani e l’inizio di quest’altra situazione, una crisi postmoderna che si poteva affrontare solo in termini sanitari.
Il tuo romanzo, tra le tante matasse di storie che si aggrovigliano e si dipanano, è anche un gran florilegio di libri, canzoni, personaggi. Tra questi, uno spazio particolare è dedicato a Courasche, la protagonista del racconto di H. C. J. von Grimmelshausen, Vita dell’arcitruffatrice e vagabonda Coraggio (Einaudi 1977). Da dove nasce il tuo interesse per questa storia scritta e ambientata a metà del ‘600?
Il mio libro si chiama L’orizzonte degli eventi, che è il termine con cui in astrofisica si indica un buco nero. Il buco nero dove alla fine non converge solo la nostra breve storia pandemica, ma tutta la storia dell’umanità. Ci siamo talmente impantanati che tutti i tempi devono tornare nella nostra testa per valutare lo stato delle cose in cui siamo, il disastro che siamo riusciti a compiere nei confronti della natura; perfino la nostra stessa capacità di evocare storie è devastata, per cui è necessario recuperare racconti del tempo contemporaneo e racconti del passato per individuare ciò che ci ha condizionato più di altro. Dobbiamo capire quando è iniziata a complicarsi il rapporto tra Storia e politica: l’inizio non può che essere l’avvio della modernità. A mio avviso, il grande rivolgimento storico politico della guerra dei trent’anni è un buon paradigma, in quanto ha determinato non solo l’equilibrio europeo e mondiale, ma ha determinato anche la forma stato e il nostro rapporto con il potere. M’è venuto in mente Grimmelshausen, perché lui, come altri autori che sono in parte citati, ha raccontato quella fase di passaggio tra il vecchio modo di avere rapporti con il potere e il modo “hobbesiano” del grande contratto sociale per cui noi rinunciamo alla nostra libertà in cambio di protezione. E però, sia Grimmelshausen che gli autori picareschi spagnoli, compreso Cervantes, mentre raccontavano questo cambio di paradigma indicavano anche che c’era qualcuno che si stava sottraendo, che non accettava il patto sociale, la nascita dello stato moderno: erano appunto i picari, figure zingaresche al margine della società. La storia dell’avventuriera Courasche (la stessa che avrebbe ispirato Bertolt Brecht per il suo Madre Coraggio)mi affascina perché è una che pur campando tramite la guerra, vivendo di guerra, sposandosi con soldati di diversi i fronti, in qualche modo riesce sempre a sottrarsi alla guerra e alla irreggimentazione: una volta sta di qua, una volta di là. Courasche capisce a un certo punto che pure questa possibilità di giocare tra una sponda e l’altra si esaurisce e quindi cerca un’ulteriore forma di libertà, si unisce agli zingari e in pochissimo tempo diventa la zingara più brava di tutte: la più brava a rubare, la più brava a leggere il futuro. Insomma, è una storia paradigmatica di un altro possibile percorso che si sarebbe potuto fare e non si è fatto, è l’utopia di libertà, la stessa che voglio raccontare attraverso gli zingari, sapendo che sono zingari ideali come quelli di Grimmelhausen o di Goethe.
Mi ha sempre colpito, all’interno della tua produzione narrativa, la centralità di altre figure “diverse”, personaggi poco prevedibili e sempre sfuggenti: penso a B. Traven, (L’arte dell’inganno Fandango, 2011), ma anche a Cagliostro (Nello specchio di Cagliostro, Il Saggiatore 2013), a Bobby Fisher (Re in fuga, Mondadori, 2008).

Sì, è vero, rappresentano un altro modo di incarnare la nostra vita sulla terra. Mi sembra che la letteratura italiana, e non solo, anche quando pienamente riuscita, sia un tentativo di approfondire, di delucidare una grande normalità dentro tutti cui stiamo vivendo da troppo tempo. Una volta che sono finite le classi, le differenze tra le persone si sono culturalmente sfumate. Questo spiega perché è diventata così dilagante l’autofiction, anche quando è ad alti livelli: perché in questa terrificante e normativa normalità si cerca di cogliere una verità ulteriore. L’altra strada è dire che questa normalità non è affatto obbligata, si può sempre essere diversi, e questo è il mio sogno che viene dagli anni ’70. Negli anni ‘70 parlavamo e ragionavamo sulla politica sempre tenendo presente questa idea della diversità. Stavamo tra Marx e Rimbaud, uno schema banalissimo, se vuoi: cambiare il mondo, Marx, e cambiare la vita, Rimbaud. Per noi, cambiare il mondo e cambiare la vita sono sempre stati la stessa cosa, e guardavamo ai diversi, ai freaks. C’è un libro fantastico di Leslie Fiedler, Freaks, un racconto della presenza del freak nel nostro immaginario collettivo, da sempre, un libro che parla dei baracconi dell’800, del film di Tod Browning, Freaks (1932), appunto, che folgorò Fiedler. Quel libro proponeva una possibile trasformazione della nostra società a partire dal diverso, da quello che non è conforme. Ho sempre pensato di far letteratura occupandomi di quello che posso trovare di diverso, di freak, ma al tempo stesso, di percorribile. Non ho la fascinazione del diverso esotico, il mio “diverso” è il ribelle dentro uno schema occidentale. E poi i personaggi in cui mi sono imbattuto, personaggi veri, che mi hanno affascinato, erano personaggi che vivevano dentro la Storia ma anche contro la Storia. Bobby Fisher, per esempio, è il caso esemplare di uno che non gliene fregava niente del mondo, voleva solo giocare a scacchi e poi diventa una figura di punta della guerra fredda, della lotta dell’America contro la Russia, un paradosso per uno che vuole stare fuori della Storia e ne diventa protagonista. Traven, a parte il fatto il fatto che non si sa davvero chi sia, era un personaggio che mi serviva per ragionare sulla fine di un certo modello politico. Traven, nella versione che sposo io e che credo corrisponda al vero, era un ex anarchico che partecipa alla repubblica dei consigli bavarese del ’19. Poi tutti vengono massacrati, compagni, dirigenti, protagonisti di questa avventura anarco-rivoluzionaria. La maggior parte vengono uccisi sul posto, altri finiscono nelle galere naziste qualche anno dopo. Traven scompare e poi si rimette a scrivere dall’altra parte dell’Oceano storie in cui la rivoluzione la fanno i contadini, gli indios messicani. Ha tentato di utilizzare la letteratura per continuare la politica quando la politica era finita e quindi, da quel lato, mi piaceva. Oppure Cagliostro: a me non interessa in sé di Cagliostro, e manco del suo inquisitore, Zelada, però mi colpiva come nel secolo dei Lumi potessero prosperare queste figure di ciarlatani. Era, come dire, l’ombra dei lumi, la famosa dialettica dell’Illuminismo: se devo scrivere un saggio, lo scrivo pensando a Horkheimer e Adorno, se devo scrivere un romanzo, lo faccio pensando a Cagliostro e a Zelada, che poi è pensare a Diderot, il campione dell’Illuminismo più libero e duttile. Non so se conosci quella lettera in cui parla dei ciechi e degli storpi eccetera: vede un mondo di normalità illuminata e poi ci stanno i ciechi gli storpi, freaks che rappresentano ciò che può smentire le pretese o l’impegno dell’Illuminismo. Insomma, quello che intendeva dire Diderot è, sì, noi vogliamo conoscere tutto, portare la ragione su tutto, però sappiamo che ci sarà sempre un lato in ombra rappresentato da quelle figure. Ecco, secondo me, la letteratura è proprio un’esplorazione dei lati in ombra, come dire, delle strade alternative, che si sarebbero potute prendere e che raramente si sono prese.
A questo riguardo, siamo in molti ad avere la sensazione di un mondo culturale italiano che si interessa dell’ovvio, invece, asfittico quando non asfissiante, tanti festival, tante manifestazioni, tanti premi e sempre le stesse persone. Tu sei giornalista, conduci le pagine culturali di Rai 3, hai partecipato a molte riviste, oltre ai romanzi hai scritto diversi saggi: come la vedi?

Mah… iniziamo chiarendo che, per quanto mi si senta a Radio 3 ogni tanto, sono tutto sommato estraneo a questa faccenda. Le riviste a cui ho collaborato sono sempre state marginali, sui giornali ho scritto poco o niente, festival mai frequentati. Però questo non è un problema della cultura, questo è un problema di quella che in termini politici si sarebbe chiamata industria culturale. Goffredo Fofi ha parlato di cultura come nuovo “oppio dei popoli”, ed è vero che troppa gente campa di cultura. Marx, quando scrive i Manoscritti economici, dice che per garantire la libertà di stampa e di conseguenza di pensiero, è necessario che la stampa non diventi un mestiere: uno scrittore non sarà mai libero finché sarà uno scrittore di professione. Lo diceva Marx, non io. L’attività di critico deve essere davvero libera, ma se campi dentro l’editoria e al tempo stesso pubblichi, partecipi, fai i premi, stai dentro un sistema che non può che autoriprodursi e si autoriprodurrà tra quella cerchia di persone, magari anche vasta ma pur sempre quella cerchia e quindi non se ne esce. L’altro aspetto è ben più grave, e mi riferisco all’asfissia culturale e mentale. La nostra cultura letteraria, per non parlare di quella politica, è povera, non ha un’idea di alternativa, cerca di raccontarci, quando va bene, con un po’ di ironia, il mondo che abbiamo accettato. Di conseguenza, pure i romanzi si assomigliano un po’ tutti più. E poi si va a mode: adesso, per esempio, sembra che si scrivano solo romance, racconti centrati sui sentimenti. Penso che di fondo ci sia un conformismo profondo derivante da mancanza di idee, di radicalità, di alternative per cui non mi stupisco che si avverta una certa asfissia nella cultura, frutto anche di pigrizie. Quando nel 2008 feci quel libro su Bobby Fisher che non era una biografia, né un saggio, qualcuno lo definì un oggetto letterario non identificato: ma se ne sono fatti diecimila di libri del genere, intendiamoci, penso a Aldous Huxley, il libro su Pere Joseph, il consigliere di Richieleu che era? Un romanzo storico? Una biografia? Era un romanzo e basta. Adesso più o meno tutti fanno questa roba, il biopic è diventato una moda. Pure sui generi abbiamo tanta pigrizia, abbiamo bisogno di incasellare, inquadrare. Pensa a uno dei grandi libri della letteratura italiana degli ultimi tempi, Piove all’insù, di Luca Rastello,è un tale mix tra memoria della sua infanzia, romanzo di fantascienza, vicende politiche anni ’70: un grande libro che non ha avuto la ricezione che meritava perché non lo potevi incasellare, non sapevi in che genere stava. Per quanto riguarda L’orizzonte degli eventi è venuto fuori che era un romanzo saggio ma per me non significa niente. Nel romanzo le idee hanno diritto di cittadinanza come i personaggi. Eisenstein nel ’27 dopo aver girato Ottobre, aveva in progetto di fare un film di fiction su sul Capitale di Marx, un libro di formule, idee: ma le idee fanno parte del liquido amniotico in cui viviamo. Nel mio libro, non c’è nessun intento saggistico, però ritengo che le idee, le letture abbiano diritto di cittadinanza come un qualsiasi altro personaggio in carne e ossa. Durante la pandemia si parlava di ciò che stava accadendo, dei virus, dei vaccini e allora che era quella? Vita o saggio? I libri che hanno paura delle idee, quelli sono la vera tragedia. Se a noi il mondo sta bene, lo dobbiamo dire che è il migliore dei mondi possibili, e lo dobbiamo pure dimostrare, ma se non ci sta bene dobbiamo dire perché non ci sta bene e cosa altro vorremmo. Invece alla letteratura italiana, di base, il mondo sta bene ma non ha il coraggio di dire che è il migliore dei mondi possibili e quindi si barcamena con i problemi più o meno seri, più o meno sentimentali di soggettività molto scarnificate, già passate attraverso l’età del narcisismo, età che porta all’era dell’io minimo, come diceva Lasch. Il narcisista non è uno che ha un grande ego, ne ha invece uno piccolo e prevedibile.
Ritorniamo, in conclusione a questa chiacchierata, al tuo libro: indubbiamente, lo scenario è tragico, dal momento che il titolo stesso, “l’orizzonte degli eventi”, altro non che è un gran buco nero dentro il quale siamo diretti, ma tu riscatti questo umore atrabiliare con una gran dose di ironia, spesso tagliente. Forse alla letteratura italiana manca proprio questa capacità di mescolare il tragico con l’ironico, non pensi?
Già, generalmente, siamo, quando va bene, di fronte a una comoda ironia che sottintende la piena accettazione del “come siamo”, riscontrabile per esempio in molti film italiani. Oppure l’altra forma di comico, versione di destra di Gianni Celati, di Ermanno Cavazzoni, sottende a uno sguardo svagato, trasognato. Nessuno mette assieme uno sguardo tragico, radicale con il fatto che anche nella tragedia, la vita è sempre un qualcosa “di più”, e quindi puoi farti pure una risata. Sono due forme di conoscenza. Non riesco a pensare una cosa cupa senza farmi una risata; non penso nemmeno che se la storia è finita, se la politica si è impantanata io debba rinunciare ad amare il mondo. L’amor mundi nasce soprattutto dal fatto che c’è un’allegria di fondo nello stare sulla terra. Il sovrapporsi di tragico e di comico non è un mix casuale, è la condizione normale ma è proprio la pavidità, la remissività della cultura italiana che impedisce di riconoscerlo. Chi scrive la cosa impegnata non può scrivere la cosa divertente, chi scrive romanzi divertenti non ci può mettere la roba seria. Il mio sguardo sulla vita è così: da un certo punto di vista mi sparerei da un altro, mi viene inevitabilmente da ridere e sono felicissimo di stare al mondo. Insomma, è perfino banale a dirsi, ma si può amare il mondo e odiare la società, per come è organizzata, dal momento che la società non esaurisce il mondo, il mondo è molto più ampio. Forse dipende anche cosa ti sei letto da ragazzo, se uno è cresciuto leggendo Friedrich Durrenmatt e Gunther Grass, il problema non si pone. Il tamburo di latta è un libro tragico ma sa far morire dal ridere. Durrenmatt per tutta la vita ha raccontato l’apocalisse ridendo. Anche nella cultura italiana, comunque: Gadda, al di là di fatti stilistici, mette assieme le due cose, Manganelli ha scritto l’Hylarotragedia, titolo programmatico. La mancanza di questa convivenza tra tragico e comico è una delle prove di un conformismo che, più che vile, è frutto di pigrizia. Il mio libro, che all’inizio ha subito diversi rifiuti perché considerato un libro cupo, è invece un libro allegro, di piena accettazione della vita. Di fronte alla catastrofe politica e culturale, la vera risposta è farsi una gran risata, uno sberleffo: dal momento che non vale neppure la pena criticare, non ci resta che fare la satira del tempo presente, con cui accapigliarsi ma col desiderio di starci, di vivere. Per me è un libro allegro, insomma.
Insomma, come dice il tuo narratore, anche tu, con gli anni, hai imparato a lasciarti andare un po’ di più, ad abbandonarti all’incerto, all’umbratile, allo scombiccherato, al grottesco, a perderti dentro ai cunicoli che si aprono dall’altra parte… E L’altra parte (Adelphi) è il titolo del libro di Alfred Kubin, uno straordinario disegnatore, quasi un nume tutelare per te. Anche tu ti sei dedicato al disegno, parlami un po’ di questa tua… altra parte.
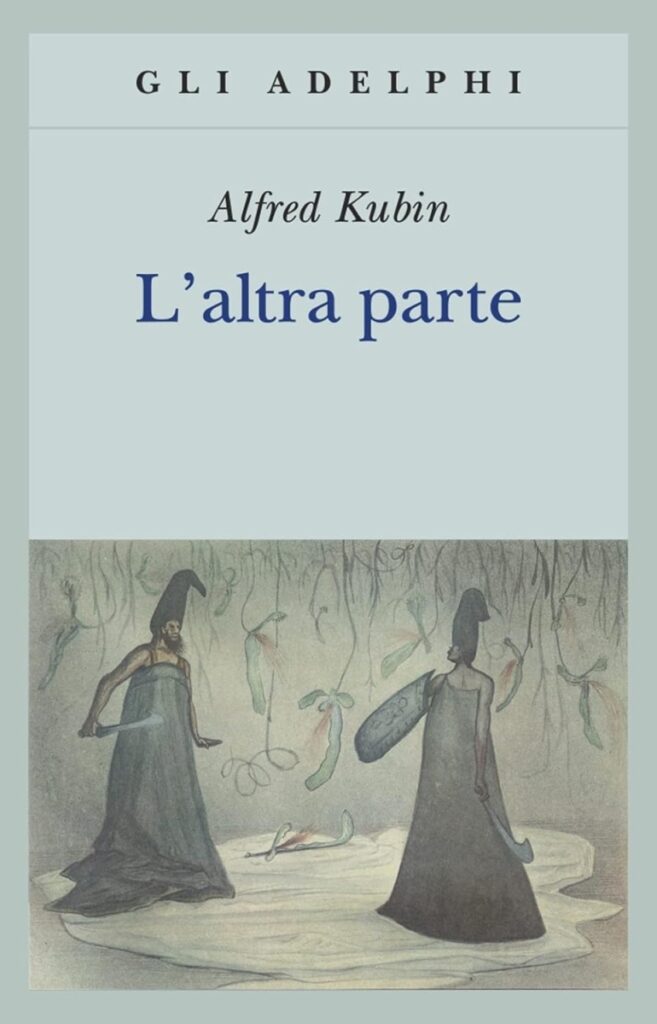
Quando ho iniziato a scrivere, ero in una fase in cui disegnavo molto. A furia di far libri che rimbalzano contro un muro di gomma uno si stufa, inoltre succedono delle cose nella tua vita privata come nella storia e dici vabbè, basta, non ho più niente da dire, o meglio, non ho più voglia di dir niente. Ma dato che non riesco a star fermo del tutto dal punto di vista creativo, mi sono messo a illustrare gli scritti di altri, da illustratore, non da artista, cercando un segno artistico che mi potesse aiutare a vedere il mondo da scrittore senza scrivere. Adesso disegno pochissimo, credo si tratti di una forma di polarità tra disegno e scrittura, per cui tutt’al più scarabocchio. La vicenda di Alfred Kubin mi colpiva per vari aspetti, in primo luogo perché il suo grande romanzo nasce da una crisi creativa, al contrario rispetto alla mia: lui disegnava, disegnava, e a un certo punto non gli riusciva più e allora che fa? Scrive un romanzo di 800 pagine, L’altra parte, esattamente la dimensione che viene presa come irruzione decisiva dell’Orizzonte degli eventi. Il sogno e la veglia si intrecciano costantemente e infatti, per me, il vero libro di culto di Kubin non è L’altra parte, ma il Disegnatore di sogni (Castelvecchi), in cui lui spiega che la componente onirica è la parte più interessante della nostra vita. Diceva che l’esperienza onirica dobbiamo viverla di giorno, non si tratta di interpretare i sogni con Freud o di trastullarsi con essi: dobbiamo capire qual è il tipo di realtà che stiamo esplorando attraverso l’esperienza onirica. I suoi disegni nascevano da un rapporto con quella parte che è in tutti noi, preponderante, un inconscio creativo. Questo mio libro sono riuscito a farlo partendo esattamente dalle sue riflessioni. Con la pandemia, la realtà era diventata talmente surreale che tanto valeva fare un passo avanti. Lo zingaro del mio romanzo non si sa bene quanto reale sia o se sia soltanto un sogno. Poi, di fatto, non è realmente soltanto un sogno ma neppure i sogni sono soltanto sogni.

Oltre al disegno, sei anche un gran appassionato di musica. Nel passato hai scritto di jazz su Coltrane e Charlie Parker, e L’orizzonte degli eventi è fitto di citazioni più o meno mascherate. Su tutti, l’immancabile Dylan, autore paradigmatico, nomadico.
Io sono nato nel ’61, Dylan è comparso a New York nel ’61… Tutte le volte che cerco di fare una ricostruzione della mia vita in quanto soggetto nel tempo, in quanto persona che ha vissuto certi anni, vado a vedere che cosa faceva Dylan in quegli anni, e mi accorgo che le sue reazioni alla Storia erano sempre o in anticipo o in ritardo. Ha sempre vissuto against the time, in reazione all’andazzo dei tempi. Tutte le volte che Dylan si inventava qualcosa, capivi che l’aria stava cambiando, stava succedendo qualcosa nella politica, nella società. Insomma, per me, Dylan è una specie di barometro dei tempi. Dylan sta lì, al di là della musica. La musica mi interessa perché è un altro linguaggio, un’altra arte che mi piace raccontare perché in fondo non la capisco. Mi costringo a seguire uno spartito che non so leggere, per dare una forma alla letteratura che sappia sorprendere anche a me: se io mi metto a raccontare John Coltrane, non sto raccontando la vita di un musicista, sto facendo un’operazione su che cos’è l’arte… Una specie di esperimento con me stesso: mi occupo con passione di una cosa che però fino in fondo non capisco, la conosco ma non la capisco intimamente, una cosa che voglio spiegare ma a partire da questa impossibilità, un modo di avere a che fare col mistero, senza nessuna mistica.
Immagine in evidenza
Vittorio Giacopini
Vittorio Giacopini – L’orizzonte degli eventi
Editore: Mondadori (27 febbraio 2024)
Lingua: Italiano
Copertina rigida: 396 pagine
ISBN-10: 8804773553
ISBN-13: 978-8804773559
Peso articolo: 490 g
Dimensioni: 14.7 x 2.7 x 22.4 cm
Vittorio Giacopini è nato a Roma nel 1961. Ha lavorato come giornalista nell’agenzia di stampa TMNews (ora askanews) e ha continuato nel mondo del giornalismo, ed è una delle voci che si avvicendano alla conduzione di Pagina 3, rassegna radiofonica della stampa letteraria e culturale che va in onda ogni mattina su Rai Radio 3. Ha collaborato a lungo nelle riviste di Goffredo Fofi, (“La terra vista dalla luna”, Lo straniero”, “Gli asini”) come autore di saggi di letteratura e critica letteraria, collaborando anche con riviste e giornali, tra cui “Il sole 24 ore” e “Il venerdì di Repubblica”. Il suo primo libro, uscito nel 1999 per Bollati Boringhieri e intitolato Scrittori contro la politica, era una silloge di suoi saggi su scrittori politici del Novecento, tra cui George Orwell, Nicola Chiaromonte, Dwight Macdonald, Carlo Levi. Nel 2009 ha curato la raccolta degli scritti politici di Albert Camus. Ha scritto anche sull’anarchico Errico Malatesta, Non ho bisogno di stare tranquillo. Errico Malatesta, vita straordinaria del rivoluzionario più temuto da tutti i governi e questure del Regno, (Eleuthera, 2012). È autore di vari romanzi, tra i quali Re in fuga del 2008 (Mondadori, vincitore del Premio Comisso), i romanzi-saggi Il ladro di suoni (Fandango 2010), L’arte dell’inganno (2011, Fandango), Nello specchio di Cagliostro, e La mappa (entrambi per il Saggiatore) con cui è entrato nella cinquina dei finalisti dell’edizione 2015 del Premio Campiello. Nel 2017 ha pubblicato il romanzo, Roma, uscito (il Saggiatore). Ha fatto più volte parte della giuria giudicante del Premio Lo Straniero, promosso dalla omonima rivista. Come illustratore collabora col settimanale “Left”, per cui ha anche illustrato i volumi Il giro del mondo in quindici reportage, Mani sulla città e C’è una favola in ogni cosa, e ha realizzato le copertine di due libri di Dakota Press, Feste Galanti di Paul Verlaine, e Poe e Rimbaud, il corvo, il battello ebbro e altre poesie . Per Sur ha illustrato “Sillabario latinoamericano”. Ha scritto insieme, a Enrico Terrinoni, e illustrato Fantasmi e ombre. Roma, James Joyce e Giordano Bruno (Sossella 2021). Nello specchio di Cagliostro (Il Saggiatore, 2013), La mappa (Il Saggiatore 2015, finalista al Premio Campiello), Roma (Il Saggiatore, 2017), Il manuale dell’eremita (ed. dell’Asino, 2018),























